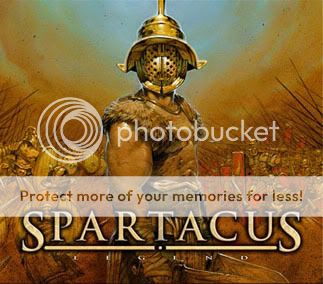 Spartaco
SpartacoSPARTACO: RIVOLTA PROLETARIA
CONTRO IL CAPITALISMO ROMANO
“Anche l’impero romano, grande ormai per aver soggiogato molte nazioni e temuto dalle altre, fu afflitto, provò gravi paure e dovette compiere grandi sforzi per evitare una catastrofe e prevalere allorché uno sparuto gruppo di gladiatori fuggì dalla sua scuola in Campania e adunò un grande esercito, guidato da tre generali, che devastò largamente e spietatamente l’Italia. Ascesero da una piccola e trascurabile banda di ladroni a regno temibile per le forze e i presidii già così potenti dei Romani […] spezzarono le catene della loro condizione servile, fuggirono, scamparono, radunarono un esercito consistente e valorosissimo; seguendo la guida e gli ordini dei loro re divennero temibili per l’intera potenza romana e invincibili per parecchi suoi generali; molto conquistarono, moltissime vittorie ottennero, gozzovigliarono a loro piacere , soddisfecero gli stimoli delle loro passioni, e insomma fino alla sconfitta, che fu ottenuta molto a stento, vissero all’altezza dei re”.
Così, ne “La Città di Dio”, Sant’Agostino ripercorre e riassume l’intera vicenda di Spartaco e della rivolta degli schiavi che per tre anni, dal 73 al 71 a.C., interessò l’intera penisola italica e mise a dura prova la collaudata macchina bellica romana. Parole cariche di disprezzo, tendenti a presentare i ribelli come un branco affamato di devastazioni[1], ed evocatrici di un clima di terrore e di pericolo assoluto. Sono, soprattutto, la conferma di come la storia di Spartaco e quella dei ribelli che lo seguirono, fosse già arricchita di elementi mitici. L’imperituro mito di Spartaco nacque nel corso degli avvenimenti stessi, sull’onda dei timori e della propaganda dell’oligarchia romana: il gladiatore trace divenne il nuovo Annibale, pronto a marciare su Roma, e un geniale stratega, mentre il pretore Crasso venne additato come il nuovo Scipione, il nuovo salvatore.
Per il “potere” Spartaco divenne simbolo del nemico pubblico, della sovversione dell’ordine costituito e della guerra interna. Il suo nome diventa, nelle successive e contrastate fasi della Roma repubblicana, un insulto per bollare d’infamia l’avversario politico. Basti un solo esempio: Cicerone nelle “Filippiche” definisce il capo popolare Antonio come “Spartaco” e “gladiatore”.
Ma la forza del mito di Spartaco la si deve alla persistente attualità della lotta per la libertà, contro ogni condizione di oppressione e servaggio. È il mito del riscatto dalla schiavitù, è il simbolo della volontà dell’oppresso di spezzare le catene. In questo senso la sua figura si ricollega alla lotta del movimento socialista, del moderno proletariato contro le metaforiche catene del capitale. Lo dimostrano le parole di Karl Marx che, in una lettera ad Engels del 1861, definisce il gladiatore come “il tipo più in gamba che ci sia posto sotto occhi di tutta la storia antica. Grande generale (non un Garibaldi), carattere nobile, realtà rappresentative dell’antico proletariato”, e quelle di Lenin che, in riferimento alla rivolta, parla di “guerre giuste, di guerre che non sarebbe lecito condannare”. E poi il nome di “Lega di Spartaco” dato al movimento rivoluzionario tedesco guidato da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg.
La diffusione del mito nel movimento operaio, comunista e socialista, è anche testimoniata da episodi “minori”: in Italia, durante la seconda guerra mondiale, i primi fogli comunisti che dovevano riattivare la lotta antifascista uscirono a Milano e Torino con i nomi “Grido di Spartaco” e “Lettere di Spartaco”[2]. È indubbio, poi, che a rafforzare questa identificazione siano state le notizie a noi giunte di specifici comportamenti di Spartaco che prefiguravano una gestione diversa della società: il divieto ai negozianti di introdurre oro e argento e ai suoi di possederne e la divisione in parti eguali del bottino (Appiano).
Scrivere la storia di Spartaco e della ribellione degli schiavi significa, quindi, andare alle radici di un mito, di più, di un simbolo, uno dei più antichi e duraturi, della lotta dell’uomo contro l’oppressione. Resta il rammarico legato alla impossibilità, allo stato attuale delle ricerche e delle fonti, di conoscere realmente l’esito della vicenda, di distinguere storia e mitologia, fatti e propaganda.
Il malessere sociale e gli schiavi. Quella di Spartaco fu solo l’ultima, certo la più imponente, delle rivolte servili che interessarono Roma. Molte infatti sono quelle che ci ha tramandato la storiografia latina. Ma, ai fini del nostro discorso, dobbiamo concentrarci sul periodo compreso tra il 135 e il 73 a.C., poco più di un secolo che ha visto ben tre rivolte di schiavi, le prime due in Sicilia, tutte in grado di mettere in qualche modo in pericolo la sicurezza repubblicana. E’ questo il periodo del “grande malessere” di Roma, della crisi profonda del suo sistema repubblicano, aperta con il tribunato di Tiberio Gracco e terminata, dopo una impressionante serie di guerre civili, con l’instaurazione del Principato all’inizio del I secolo d.C. Si tratta di un malessere che indebolisce l’esausto tessuto di una società uscita vittoriosa da una lunga serie di guerra di conquista.
Con le distruzioni di Cartagine e Corinto, avvenute entrambe nel 146 a.C., Roma divenne la superpotenza indiscussa del Mediterraneo, ma l’ampliamento territoriale non fu accompagnato da un’equa distribuzione delle ricchezze. Sconfitti non furono solo i popoli nemici, ma anche i piccoli e medi agricoltori romani che costituivano il nerbo delle legioni vittoriose. I guadagni più consistenti ingrossarono le tasche dell’”ordo senatorius”, di quel ristretto numero di famiglie che si spartivano le cariche pubbliche, e del nascente “ordo equester”, costituito da intraprendenti rampolli del ceto senatorio che si lanciarono nel lucroso traffico commerciale e nello sfruttamento delle nuove province.
Medi e piccolo coltivatori, invece, si trovavano sull’orlo del lastrico e ridotti al rango di “proletarii”, cioè cittadini romani la cui unica ricchezza era la prole. Privi di capitali per apportare miglioramenti ai terreni e pressati dalla concorrenza dei grandi latifondi e delle “villae senatorie”, si trovavano di fronte a soluzioni come quella della vendita a basso costo della proprietà, del lavoro come braccianti oppure della migrazione in città per vivere alla giornata, ingrossando le fila di una massa politicamente manovrabile, inquieta, pericolosa e da tenere a bada con il sistema della frumentazioni.
La risposta della classe dirigente senatoria fu l’assoluta ostilità ad ogni progetto, come quello graccano, di distribuire parte delle vaste estensione dell’”ager publicus”. Posizione ovvia se si pensa che le famiglie nobili se ne erano fatte assegnare vaste porzioni (“villae” e “latifundia”) in concessione a tempo indeterminato o dietro il pagamento di canoni irrisori. In quest’ottica appare illuminante l’amara considerazione dello storico e filologo Mommsen: “si poteva ormai gridare ad alta voce che nel foro della capitale, le bestie avevano il loro covile, ma ai cittadini non erano rimasti che l’aria e il sole, e, quelli che si chiamavano i signori del mondo, non possedevano più una zolla”. Difficile quindi stupirsi del fatto che alle rivolte degli schiavi partecipassero anche uomini liberi, che nulla avevano da perdere, come i piccoli agricoltori, i pastori e braccianti impoveriti e appesantiti dai debiti,.
Ancora più dura era la condizione della maggior parte degli schiavi affluiti a Roma e in Italia sulla scia dell’espansione territoriale: tra II e I secolo a.C. possiamo, infatti, parlare dell’arrivo nell’Urbe di circa un milione di schiavi. Solo una parte era costituita da prigionieri di guerra, la maggiore, invece, era il risultato di un vasta e ramificata rete commerciale. Provenienti da vere e proprie razzie e cacce all’uomo operate, soprattutto in Asia anteriore, da pirati cretesi e cilici in concorrenza con gli appaltatori romani che le ordinavano negli Stati clienti, venivano acquistati da affaristi in centri specializzati. Tra questi, il più “rinomato” era quello di Delo nel quale, secondo la testimonianza di Strabone, si contavano fino a diecimila vendite al giorno.
Oltre ai diritti legati alla cittadinanza romana, di cui godevano tutti i romani indipendentemente dalla situazione economica, ad essi era negata la piena appartenenza all’umanità. Erano, sull’onda della lezione aristotelica, considerati “macchine umane”, “strumenti vocali” e, in generale, strumenti d’azione per il padrone, utili solo fino a quando erano in grado di produrre. Già Mommsen, forse esagerando nel paragone, aveva aperto uno squarcio su un mondo tenuto nascosto dalla cultura e dal potere romano: “Gli infiniti guai e le gravi miserie che in questo più misero fra i proletariati ci stanno innanzi, può solo comprenderli chi ardisce di spingere lo sguardo in un simile abisso; è assai probabile che paragonate a quelle degli schiavi romani le sofferenze di tutti i negri insieme siano un nonnulla”.
A dispetto di una minoranza impiegata in attività industriali o commerciali per conto dei loro padroni, con mansioni che noi potremmo definire da “professionisti”, gli schiavi erano in gran parte utilizzati come manodopera nei latifondi e nelle grandi aziende agricole, la cui produzione era orientata al mercato, sotto gli occhi vigili e spietati dei “villici”, schiavi che godevano della fiducia dei padroni.
Privati di ogni libertà e sottoposti alla volontà assoluta ed incondizionata del padrone (“dominicia potestas”), erano soggetti ad un vero e proprio regime di terrore in cui la tortura e la marchiatura a fuoco erano pratiche abituali. A Roma operavano tranquillamente imprese che su commissione dei padroni prendevano in appalto la preparazione e l’esecuzione dei supplizi da infliggere agli schiavi più riottosi. Non da meno era la condizione dei gladiatori, non tutti comunque schiavi, i quali, attraverso il rito dell’”auctoramentum” si ponevano sotto l’autorità assoluta del padrone, obbligandosi a farsi bruciare, percuotere, incatenare e senza alcuna possibilità di rifiutare di sfidarsi nel circo.
Il quadro è, dunque, quello di una condizione di abbrutimento fisico e morale al quale le sole possibile alternative potevano limitarsi al suicidio o alla disperata ribellione. In questo senso le ribellioni servili non vanno lette come finalizzate alla scomparsa dell’istituto schiavistico, obiettivo che nessuna si diede, ma come risposta ai maltrattamenti e alle umiliazioni ricevute, e ricerca di una libertà perduta.
Nell’animo dei ribelli, prima uomini completi, era vivo l’orgoglio nazionale e l’attaccamento alla patria perduta. Basti pensare al comportamento degli Iberi di Numanzia, città ribelle ed orgogliosa rasa al suolo dai Romani nel 133 a.C, che, fatti prigionieri, preferirono ammazzarsi l’uno con l’altro pur di non vedersi schiavizzati. Quanto mai centrato a questo punto è il monito di Diodoro Siculo: “Chiunque ha avuto il destino di essere di bassa condizione sociale, cede il passo volentieri a chi ha più fama e fortuna, ma se non gli viene riconosciuta nemmeno l’umanità che gli è dovuta, diviene nemico di chi lo comanda in modo così violento”.
Prima di quella di Spartaco, due rivolte servili, entrambe scoppiate in Sicilia nel giro di trent’anni, misero in allarme il potere romano. La Sicilia, strappata da Roma a Cartagine nel 241 a.C. al termine della prima guerra punica, assicurava alla repubblica, grazie alla sua fertilità, un cospicuo rifornimento annuo di frumento ed un ingente gettito fiscale, assicurato dalla voracità delle “società dei pubblicani”. In questo senso, la presenza romana faceva sentire tutto il suo peso sulla provincia.
Alla base della catena produttiva c’era una numerosa e crescente manodopera servile impiegata nelle miniere e, soprattutto, nelle campagne: “Tutta la Sicilia - racconta Diodoro Siculo - fu così inondata da una massa di schiavi: una massa tanto grande che chi ne udiva l’enorme numero non ci credeva”. Gli schiavi, nati come uomini liberi, provenivano principalmente da zone del Mediterraneo orientale civilizzate e di tradizione culturale ellenica come la Siria.
Costretti a vivere in situazioni penose, erano tacitamente autorizzati dai padroni ad armarsi e dedicarsi al banditismo e al brigantaggio nei confronti della popolazione locale. Una sorta, quindi, di pericolose e difficilmente controllabili milizie private.
I maltrattamenti sono all’origine della prima rivolta scoppiata nel 135 a.C. A ribellarsi alla crudeltà del padrone, un certo Damofilo uso a bollarne con marchi di ferro i corpi, furono ben quattrocento schiavi che, all’ordine del siriano Euno, assalirono e saccheggiarono Enna. Nella città venne convocata una vera e propria “assemblea costituente” che proclamò Euno re con il nome di Antioco, nome tipico dei sovrani siriani della dinastia dei Seleucidi. Fu il primo passo per la creazione di un potere indipendente sull’isola, cui seguirono la nomina di un primo ministro, il conio di una nuova moneta, la costituzione di un esercito ben armato e le prime misure per la tutela dell’ordine pubblico e la difesa di beni e persone (limitazione dei saccheggi).
Ma Roma non poteva certo tollerare la perdita del controllo sulla ricchissima provincia. Ci vollero ben quattro azioni militari per porre termine alla ribellione: dopo le sconfitte degli eserciti comandati da Lucio Ipseo e poi del console Caio Fulvio Flacco, la vittoria decisiva arrivò solo nel 132 a.C. con l’occupazione di Enna per opera del console Publio Rupilio. Il “re” Euno fu sbattuto in carcere a marcire divorato dai parassiti.
Diverse furono le cause scatenanti della rivolta scoppiata nel 104 a.C., anno in cui il console Mario chiese al re di Bitinia di inviare contingenti militari per affrontare la guerra contro i Cimbri che, l’anno precedente, avevano annientato due legioni romane ad Arausio (Orange). La riposta del sovrano asiatico fu che non poteva esaudire la richiesta perché gran parte degli uomini abili alle armi era stata razziata e si trovava in schiavitù nei latifondi della province romane. Come abbiamo visto, una pratica a dir poco tollerata da Roma. Ma, di fronte al pericolo, il Senato questa volta ordinò una inchiesta per dichiarare libere le persone vittime di una tale ingiustizia. Tuttavia, dopo le prime liberazioni di schiavi bitinici, l’operazione si interruppe di fronte alle proteste dei potenti ed influenti proprietari che li avevano acquistati legalmente.
Fu la delusione per la mancata liberazione che spinse gli schiavi alla rivolta. Si riunirono a Siracusa per giurarsi fedeltà (“coniuratio”) e convocare un’assemblea che elesse il proprio re nella persona di Savio, successivamente nominato re Trifone allorquando si unirono gli schiavi ribelli guidati dal cilicio Atenione. Come nella precedente rivolta, venne messo in piedi un valido esercito, forte di ventimila fanti e duemila cavalieri. La rivolta venne sedata nel 101 a.C. dal console Manlio Aquilio. Mentre Trifone venne ucciso in guerra, Atenione e altri furono spediti a Roma per lottare nel circo contro le belve. Ma il finale fu un altro: come racconta Diodoro Siculo, i prigionieri “si rifiutarono infatti di combattere contro le belve, ma si sgozzarono l’un l’altro sui pubblici altari”.
Prima di passare alla rivolta guidata da Spartaco, occorre, a questo punto, sottolineare due importanti fatti relativamente alle due rivolte siciliane: che vi parteciparono braccianti liberi e piccoli agricoltori impoveriti e che lo scopo principale dei ribelli, animati da forti sentimenti nazionali, non fosse l’abolizione della schiavitù, ma quello di riacquistare la libertà perduta attraverso la costituzione di un potere indipendente sull’isola.
A differenza degli schiavi siciliani, i gladiatori che si ribellarono nel 73 a.C. provenivano da nazioni non ancora entrate nell’orbita di Roma, come la Gallia transalpina, la Germania e la Tracia. Nazioni che, all’epoca, venivano definite “barbare” e “incivili”. Dall’ultima citata arrivava Spartaco, la cui storia precedente alla ribellione resta nascosta nella nebbia. Secondo gli storici Appiano e Floro, prima di diventare gladiatore, aveva combattuto per l’esercito romano per poi disertare. Il Mommsen aggiunge l’ipotesi che fosse un rampollo della famiglia degli Spartochidi, saliti al trono della Tracia.
Di certo, quindi, non nacque come schiavo. Plutarco, nel profilo dedicato a Crasso, si sofferma su un episodio, non si sa quanto reale, estremamente rivelatore della futura grandezza del trace: portato a Roma per essere venduto, mentre dormiva un serpente gli si avvinghiò in volto e la moglie, profetessa “invasata da Dioniso”, dichiarò che il prodigio annunciava una “forza grande, spaventosa”. Lo stesso storico ha poi per lui parole di elogio: “dotato non solo di grande coraggio e di forza, ma anche di intelligenza ed educazione superiore a quanto ci si aspetterebbe da una persona della sua condizione: piuttosto ellenica, insomma”[3].
Nata da un episodio di modesta importanza, la ribellione degli schiavi guidati da Spartaco, inizialmente sottovalutata, si impose a poco a poco, con “andamento alluvionale” come ben sintetizza Dogliani, così da costringere l’esercito romano a tre anni di dura lotta in gran parte della penisola. Presentato dalla propaganda romana come un novello Annibale, Spartaco, a differenza del condottiero cartaginese, dovette far fronte alle molte divisioni, anche nazionali, che attraversavano il suo campo, non riuscì ad occupare stabilmente città in modo da farne basi di rifornimento e riorganizzazione. Privo di un preciso disegno strategico, dovette difendere la libertà propria e dei suoi con una guerra per bande, utilizzando le tattiche tipiche della guerriglia; l’unica vera battaglia campale fu per lui e per i suoi quella fatale.
Mentre Roma era in lotta contro la carestia e i suoi eserciti erano impegnati nel Ponto contro Mitridate e in Spagna contro Sertorio, a Capua, città più importante della Campania, una settantina di gladiatori si ribellarono alla dura disciplina della scuola di Gneo Lentulo Batiato. A guidarli erano in tre: il trace Spartaco e i celti Crisso ed Enomao. La prima tappa dei rivoltosi, armati di strumenti gladiatori, coltelli e armi sottratte a pattuglie romane, fu l’impervio Vesuvio dove, a poco a poco, emerse la personalità di Spartaco che si impose, anche se mai interamente, sugli altri. La sottovalutazione del pericolo fu fatale per le prime reazioni romane. Il propretore Claudio Glabro, intenzionato ad assediarli con tremila uomini in attesa di rinforzi, venne beffato dagli schiavi e assalito alle spalle; annientate furono poi le truppe del pretore Varinio che gettò allo sbaraglio i suoi quattromila uomini.
Questi primi successi permisero a Spartaco di raccogliere nuovi consensi tra gli schiavi e i disperati della zona e di agire liberamente nell’agro campano mettendo a sacco Nola e Nocera e poi Turii e Metaponto in Lucania. Plutarco parla dell’arrivo di “molti mandriani e pastori della regione che, gente giovane e robusta, si unirono ad essi”. Tra combattenti e simpatizzanti locali si può, a questo punto, parlare di settantamila effettivi operanti per bande indipendenti. Il numero stesso, come anche le diverse fonti latine, testimoniano dell’improbabilità che i ribelli fossero solo schiavi. Fu a questo punto che il Senato pensò di inviare l’esercito sotto la guida dei consoli dell’anno 72 Gellio Publicola e Cornelio Lentulo Clodiano.
Il timore era quello che i rivoltosi passassero dalla Calabria in Sicilia e causassero gravi problemi nel “granaio” di Roma. Gellio attaccò i ribelli da sud, sconfiggendo i trentamila agli ordini di Crisso e uccidendone ben ventimila, mentre Spartaco riuscì ad evitare lo scontro frontale e a causare gravi perdite alle truppe di Clodiano. Inoltre, nella sua inarrestabile marcia verso nord, sconfisse sonoramente il proconsole della Gallia Cisalpina Caio Cassio Longino. Spartaco, ormai capo indiscusso, celebrò le vittorie costringendo tremila prigionieri romani ad affrontarsi all’ultimo sangue in una sfida gladiatoria di fronte a tutto il suo esercito.
Per il Senato era ormai vero allarme e la soluzione, come in tutti i casi di estremo pericolo, fu quella di concentrare nell’autunno del 72 a.C. poteri illimitati nella persona del pretore Marco Licinio Crasso, un ricco aristocratico che aveva combattuto al fianco di Silla e già famoso per la sua brutalità: sua l’idea di riportare in auge le decimazioni per mantenere la disciplina tra le truppe.
Insignito della carica di proconsole, mise in campo dieci legioni, di cui sei arruolate personalmente. Spartaco e il suo esercito, nel ripiegamento a sud, avevano raggiunto la punta estrema del Bruzzio (odierna Calabria), circondati per tre quarti dal mare con il rischio di essere seriamente intrappolati. E questo fu il piano di Crasso; fece costruire, con un grande sforzo d’ingegneria, un accerchiamento da mare a mare costituito da una lunga palizzata in legno e un ampio fossato (55 km) in modo da chiudere ogni via di fuga e di rifornimento ai ribelli. Il rischio, per questi, era di morire lentamente di fame. I primi tentativi di fuga costarono la vita a ben dodicimila uomini. Ma una sera, col favore della nebbia, Spartaco riuscì ad attraversalo con una parte dei suoi e a dirigersi verso Brindisi. Le parti si ribaltarono: questa volta erano i romani che rischiavano di essere intrappolati.
Per il senato era davvero troppo; si decise di richiamare in Italia le truppe di stanza in Macedonia, comandate da Marco Terenzio Varrone Locullo, e quelle di Pompeo, impegnate in Spagna contro Sertorio. Ma Crasso, acerrimo nemico di Pompeo, decise di avventarsi subito all’inseguimento dei rivoltosi e ottenne una importante vittoria contro i distaccamenti ribelli guidati dai galli Casto e Ginnico che, alla fine, persero ben trentacinquemila uomini. A questo punto fu Spartaco, timoroso di un accerchiamento dopo lo sbarco a Brindisi delle legioni di Locullo, a dover prendere l’iniziativa e passare all’attacco.
La battaglia si svolse in una zona imprecisata tra la Lucania e l’Apulia e ad uscirne vincitore fu Crasso che uccise settantamila ribelli. A Pompeo spettò il merito di porre la parola fine alla rivolta massacrando le ultime bande di sopravvissuti incontrati in Etruria. Così, nella primavera del 71 a.C., per Roma finiva l’incubo.
E Spartaco? Secondo Plutarco, il gladiatore trace uccise il suo cavallo prima di gettarsi nella mischia in cerca di Crasso; uccise due centurioni, ma venne poi circondato e abbattuto da numerosi altri. Secondo Appiano, invece, venne ferito alla coscia da un giavellotto ma continuò a combattere in ginocchio fino a quando non venne accerchiato. Il suo corpo, però, non venne più ritrovato.
Ai seimila ribelli prigionieri toccò, per decisione di Crasso, la crocifissione lungo la via Appia, sul tratto che collegava Roma con Capua. Al generale romano, vincitore di una guerra contro schiavi e fuggiaschi, non venne però concesso l’onore del trionfo. Anche in questo modo Roma toglieva dignità ai ribelli.
di Diego Bertozzi
NOTE
[1] T. Mommsen, nella sua monumentale Storia di Roma parla di 'sollevazione di masnadieri', di 'orde selvagge'.
[2] Informazioni tratte da Nascita di una democrazia, Luigi Cortesi, manifestolibri, Roma, 2004, pag. 135.
[3] Anche Mommsen ha parole di elogio per Spartaco: 'talento strategico' e 'un non comune ingegno organizzatore'.
http://www.storiain.net


